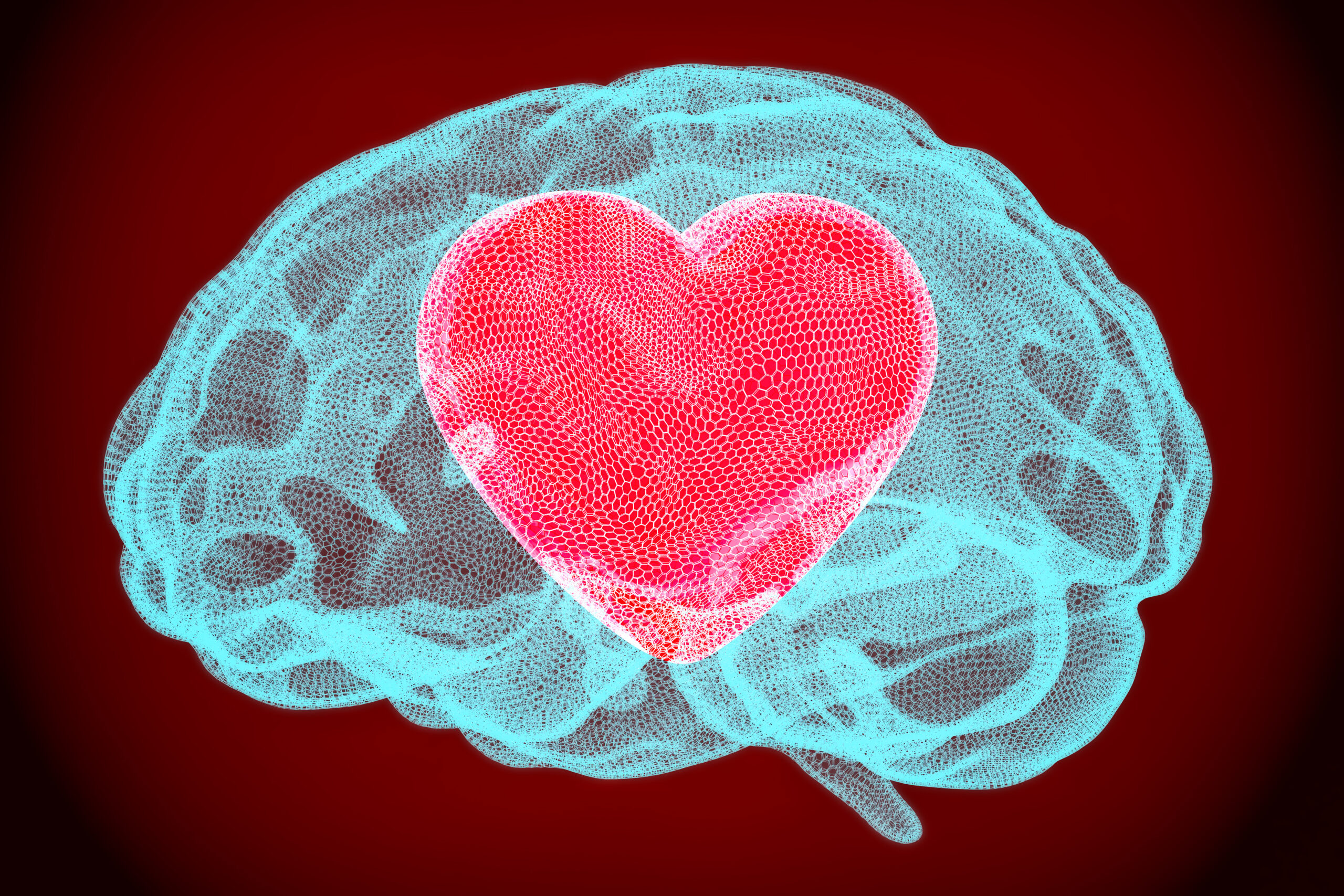Pubblicato il 02/10/2025
Resistenza fisica e stress: come reagisce il corpo in condizioni estreme?
Dalla tragedia delle Ande a La società della neve: cosa ci insegna il corpo umano nella lotta per la sopravvivenza
Nel 1972, un aereo uruguaiano si schiantò tra le vette gelide della Cordigliera delle Ande.
A bordo c’era una squadra di rugby, i loro familiari e amici. Il disastro aereo si trasformò in un dramma di sopravvivenza che per più di due mesi mise alla prova i limiti fisici e psicologici di chi riuscì a restare in vita.
A distanza di decenni, quel racconto estremo di resistenza è tornato all’attenzione del grande pubblico grazie al film La società della neve, che ha riaperto una riflessione profonda su come il corpo umano reagisca in condizioni estreme.
La risposta del corpo allo stress estremo non è soltanto una questione di forza di volontà.
Entra in gioco un complesso sistema biologico che modifica funzioni vitali, ricalibra le priorità dell’organismo e cerca di garantire la sopravvivenza a ogni costo.
In questo scenario, il corpo si rivela non solo una macchina straordinaria, ma anche un organismo fragile, capace di adattarsi e allo stesso tempo vulnerabile alle sollecitazioni prolungate.
La prima fase: il cortisolo prende il comando
Quando si è esposti a un evento traumatico improvviso, come un incidente aereo o la consapevolezza di essere isolati a oltre 3.000 metri di quota, senza cibo e riparo, il corpo attiva immediatamente una risposta ormonale guidata dal sistema nervoso simpatico.
Il cortisolo, noto come l’ormone dello stress, entra in circolo insieme all’adrenalina, preparandoci a reagire.
Questa fase, spesso descritta come “fight or flight”, è caratterizzata da un’accelerazione del battito cardiaco, dilatazione delle pupille, aumento della glicemia e una temporanea soppressione di funzioni non essenziali, come la digestione.
Il corpo si concentra su un unico obiettivo: sopravvivere nel breve termine.
La progressiva adattabilità: il corpo si ricalibra
Nelle ore e nei giorni successivi al trauma iniziale, se la situazione estrema si protrae, il corpo cambia strategia.
Non può restare in uno stato di allerta permanente senza pagarne un prezzo altissimo.
Entra così in una fase di adattamento, dove vengono risparmiate energie, ridotte le funzioni cognitive meno rilevanti e modificate le soglie di dolore e fame.
Nel caso dei sopravvissuti delle Ande, questo processo fu evidente.
Dopo le prime ore di choc, iniziarono a cercare soluzioni: usarono i sedili come riparo, sciolsero la neve per bere, crearono sistemi rudimentali per mantenere il calore corporeo.
In quei momenti, il corpo non si limita a “resistere”, ma assume una logica nuova: ridurre al minimo gli sprechi energetici e conservare le risorse vitali.
Il ruolo del freddo estremo: nemico silenzioso e costante
A oltre 20 gradi sottozero, il corpo umano entra in una battaglia costante contro l’ipotermia.
La temperatura corporea deve restare attorno ai 37 gradi per garantire il funzionamento degli organi interni.
Al di sotto dei 35 gradi, si parla già di ipotermia lieve, che può diventare moderata o grave quando la temperatura scende ulteriormente.
In condizioni di freddo estremo, il sangue viene deviato verso gli organi vitali.
Le estremità, mani, piedi, naso, orecchie, diventano sacrificabili. È qui che subentra il rischio di congelamento.
Inoltre, il metabolismo accelera per produrre calore, ma senza apporto calorico, le riserve si esauriscono rapidamente.
Il corpo umano sa anche rispondere a questa aggressione con strategie estreme: rallenta le funzioni cognitive per risparmiare ossigeno, abbassa il consumo energetico e, nei casi più avanzati, può persino entrare in uno stato simile al torpore.
Fame e cannibalismo: oltre il limite morale, sotto pressione biologica
Uno degli aspetti più controversi e noti della tragedia delle Ande riguarda la scelta, da parte dei sopravvissuti, di nutrirsi dei corpi delle vittime per evitare di morire di fame.
Una scelta che, a distanza di decenni, continua a provocare discussioni etiche, ma che sul piano fisiologico racconta molto della nostra natura.
La fame prolungata innesca un processo che porta il corpo a consumare prima le riserve di glucosio, poi i grassi, infine le proteine dei muscoli.
Si tratta di un deterioramento progressivo che conduce a debolezza estrema, confusione mentale, perdita di lucidità.
In alcuni casi, la percezione del tempo e dello spazio si altera, e il corpo si avvia verso il collasso.
Mangiare, in quella condizione, non era un atto di disperazione emotiva, ma una risposta fisiologica urgente e necessaria per mantenere attive le funzioni vitali.
È una delle testimonianze più drammatiche del potere che il corpo ha e pretende di sopravvivere, anche a costo di superare ogni tabù culturale.
L’importanza della mente: il corpo segue la psiche
Se la fisiologia guida i meccanismi della sopravvivenza, è la mente a fornire il motore iniziale e a mantenerlo attivo.
Studi su situazioni estreme, da naufragi a carcerazioni prolungate, hanno dimostrato che chi riesce a mantenere uno scopo, un legame affettivo immaginato o reale, una visione futura anche incerta, ha maggiori probabilità di sopravvivere.
Nel film La società della neve, così come nei racconti autentici dei superstiti, emerge chiaramente questo aspetto: la volontà di non lasciarsi andare, di dare senso al dolore, di lottare non solo per sé stessi ma per chi è accanto, può essere la forza che tiene in vita quando il corpo da solo non basta più.
Cosa ci insegna il corpo umano: adattabilità, limite, speranza
La tragedia delle Ande ci ha lasciato una testimonianza estrema, ma anche profondamente umana.
Ogni essere umano ha dentro di sé risorse che non conosce finché non viene messo alla prova.
Il corpo, in simbiosi con la mente, è capace di mutare, rallentare, riprogrammarsi pur di sopravvivere.
Ma non è invincibile.
L’energia si consuma, le riserve finiscono, e la vulnerabilità resta un tratto essenziale della nostra condizione.
Comprendere come reagisce il corpo in condizioni estreme non serve solo a spiegare eventi eccezionali.
È un modo per riflettere sulla nostra resilienza quotidiana, sulle sfide del presente e sul valore che diamo alla vita anche nei momenti più bui.