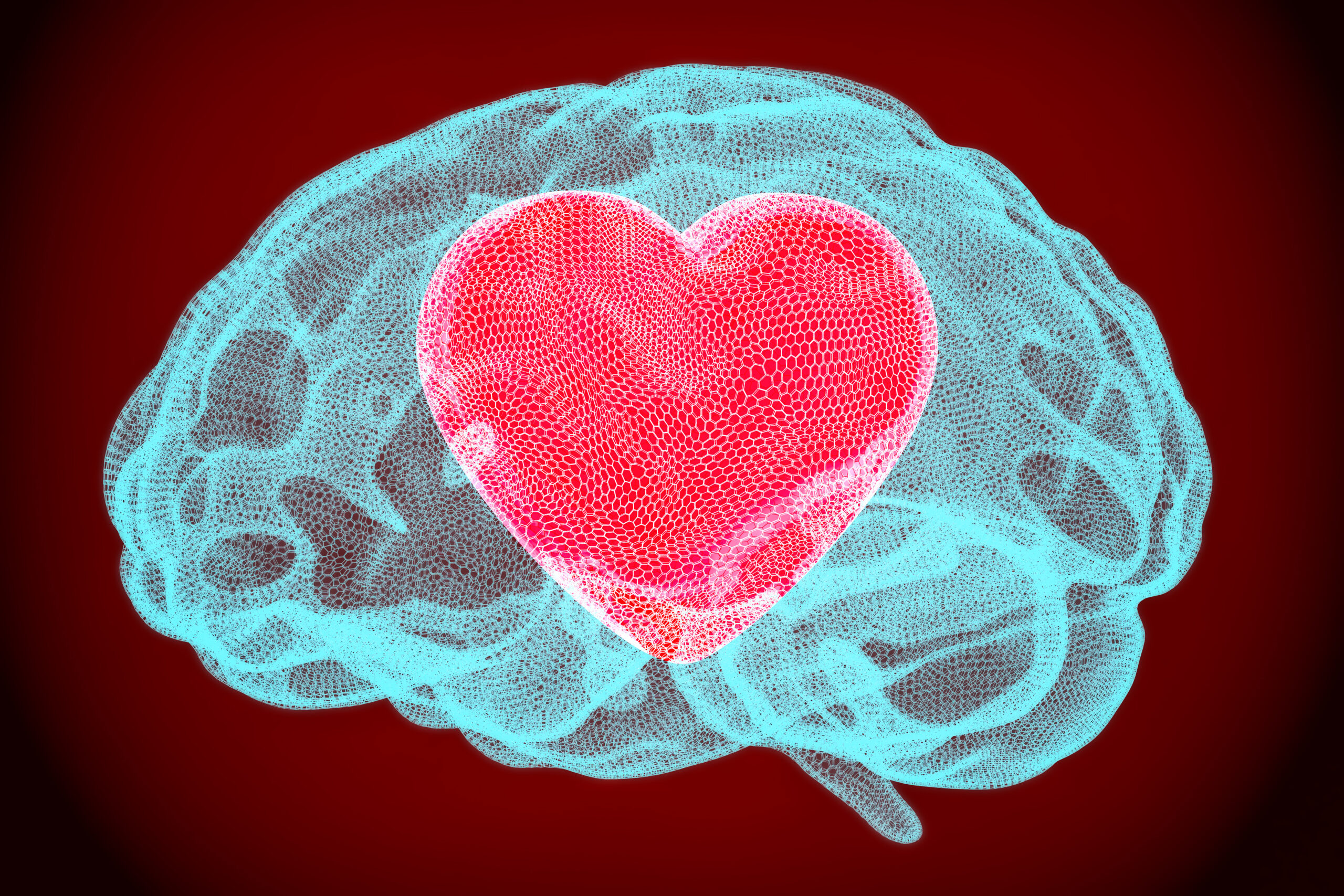Pubblicato il 03/11/2025
Sindrome dell’intestino irritabile e asse intestino-cervello
Un disturbo diffuso e debilitante
La sindrome dell’intestino irritabile è un disturbo gastrointestinale funzionale molto diffuso, caratterizzato da sintomi come diarrea, stitichezza e altre manifestazioni che influenzano significativamente la qualità della vita delle persone che ne soffrono.
Colpisce soprattutto adulti giovani e di mezza età, in particolare nella fascia compresa tra i 20 e i 40 anni.
Le statistiche evidenziano che dal 10% al 15% della popolazione adulta convive con questa condizione, con una prevalenza leggermente maggiore nelle donne rispetto agli uomini.
Già da tempo è emerso che lo stile di vita e le abitudini alimentari incidono sull’insorgenza e sull’andamento della sindrome: stress, abitudini alimentari irregolari e consumo eccessivo di cibi irritanti rappresentano fattori capaci di aumentare il rischio o di aggravare i sintomi.
Tuttavia, nonostante la sua diffusione, i meccanismi precisi che determinano la sindrome dell’intestino irritabile restano ancora poco chiari.
La ricerca suggerisce comunque che la regolazione neurologica ed ormonale, lo squilibrio della flora batterica intestinale e le risposte infiammatorie svolgano un ruolo cruciale nel suo sviluppo e nella sua manifestazione clinica.
Microbiota e disbiosi
Un aspetto centrale riguarda proprio il microbiota intestinale, ossia l’insieme dei microrganismi che popolano l’intestino.
Nei pazienti con sindrome dell’intestino irritabile, la sua struttura subisce spesso alterazioni, con una riduzione dei batteri benefici e un aumento dei batteri patogeni.
Questa condizione, nota come disbiosi, può indebolire la funzione di barriera intestinale e favorire risposte infiammatorie più intense.
Ne derivano conseguenze dirette sulla funzione gastrointestinale e sulla comparsa dei sintomi tipici del disturbo.
L’attenzione della ricerca si è concentrata molto su questo punto, perché la perdita di equilibrio microbico sembra rappresentare un elemento determinante non solo nella salute intestinale, ma anche in processi che coinvolgono il sistema nervoso e la regolazione emotiva.
Non a caso, nel 2016, il consenso di Roma IV, risultato di una conferenza internazionale, ha fissato i criteri diagnostici della sindrome e ha rafforzato l’idea dell’esistenza di un asse intestino-cervello, una rete di comunicazione capace di spiegare parte delle interazioni alla base del disturbo.
L’asse intestino-cervello
L’asse intestino-cervello è infatti un sistema di comunicazione bidirezionale che collega il tratto gastrointestinale con il sistema nervoso centrale.
Il suo ruolo è quello di monitorare e integrare le funzioni intestinali, collegando i centri emozionali e cognitivi del cervello con i meccanismi periferici dell’intestino.
Questa rete coinvolge vie neurali, ormonali, immunitarie e microbiche, ed è proprio il microbiota a svolgere un ruolo cruciale nel mantenimento di questo equilibrio.
Studi hanno mostrato che il cervello è in grado di regolare motilità, secrezione e permeabilità intestinale attraverso il sistema nervoso autonomo e i neurotrasmettitori, influenzando così in maniera significativa la struttura e la funzione del microbiota.
Allo stesso tempo, alcuni batteri presenti nell’intestino hanno la capacità di sintetizzare neurotrasmettitori importanti anche per il sistema nervoso centrale, come la serotonina.
Quest’ultima, oltre al suo noto ruolo nella regolazione dell’umore, è strettamente legata ai sintomi della sindrome dell’intestino irritabile: può aumentare la permeabilità epiteliale, attivare l’ipersensibilità viscerale, stimolare le cellule immunitarie e modificare la motilità intestinale, rendendo più intensi i disagi dei pazienti.
Le implicazioni della disbiosi
La disbiosi, dunque, non si limita a generare effetti locali, ma porta a cambiamenti significativi nei neurotrasmettitori, negli ormoni e nei metaboliti microbici.
Questi fattori sono in grado di attivare il sistema nervoso enterico e di influenzare la funzione del sistema nervoso centrale, suggerendo una connessione molto più profonda di quanto si pensasse in passato.
Nell’ultimo decennio, nuove evidenze hanno ampliato la comprensione di questa relazione bidirezionale, mostrando come il microbiota non agisca soltanto a livello intestinale, ma interagisca direttamente con il cervello attraverso vie neuroendocrine e metaboliche.
La ricerca ha dimostrato che il microbiota intestinale è indispensabile per lo sviluppo e il corretto funzionamento del cervello dei mammiferi e che rappresenta un elemento chiave in diversi processi fisiologici.
Una condizione multifattoriale
La sindrome dell’intestino irritabile, alla luce di queste conoscenze, si conferma quindi come un disturbo complesso e multifattoriale, in cui l’intestino e il cervello dialogano costantemente.
Non si tratta solo di un problema digestivo, ma di una condizione che coinvolge reti di comunicazione che spaziano dal sistema immunitario al sistema nervoso, passando per l’attività dei microrganismi intestinali.
Comprendere questo intreccio è fondamentale non soltanto per diagnosticare correttamente la sindrome, ma anche per individuare approcci terapeutici che tengano conto della sua natura integrata.
Il ruolo dello stile di vita, dell’alimentazione, dello stress e soprattutto dell’equilibrio microbico appare oggi decisivo: sono tutti elementi che possono favorire o, al contrario, attenuare i sintomi, contribuendo a determinare la qualità di vita dei pazienti.